
Conosco Valerij per caso, a Kiev nel 1991 per le elezioni che portano all’indipendenza dell’Ucraina. Fa l’operatore per la tv locale. Parliamo di Chernobyl: “Sta a cento chilometri da qui, se vuoi ti ci porto”. Sono passati appena cinque anni dall’apocalisse, nessun giornalista occidentale c’è mai stato. Sono poi andato altre due volte, per il decennale e per il ventennale, ma erano visite guidate, insieme a orde di macabri turisti che hanno addirittura pagato per sentire i brividi, niente a che vedere con l’impatto “nature” dell’esordio, faccia a faccia con quello che è stato definito il monumento funebre alla prima era nucleare.
Il primo viaggio (1991). Chernobyl in ucraino significa “le piante che crescono nella palude”. Una volta la zona serviva per nascondersi da mongoli e tartari. Il territorio è stato diviso in quattro zone che corrispondono ai vari livelli di contaminazione. Un visitatore normale, superando molti controlli, può arrivare al massimo fino al fiume Zdvizh, cioè al livello numero due. Al di là, dove il tasso di radiazione è superiore di cinquanta volte a quello normale, è assolutamente proibito entrare. Grazie a Valerij ci fanno passare. Ma bisogna lasciare l’auto, salire su un pullmino della stazione e rispettare certe regole. Soprattutto non superare il limite di permanenza, fissato in cinque ore. “Sarebbe molto pericoloso andare oltre” ci spiegano “perchè la polvere radioattiva avrebbe il tempo di fermarsi”.
Entriamo dunque nella zapretnaya, la zona proibita. Attraversiamo diversi villaggi fino a raggiungere Pripyat, la città fantasma. “Il partito di Lenin è la forza del popolo che porta al trionfo del comunismo” c’è ancora scritto all’ingresso. La città è proprio a ridosso della centrale. Qui abitavano sessantamila persone: tutti i dipendenti della stazione con le loro famiglie. E’ stata abbandonata in fretta quella notte, adesso è una città morta, popolata solo dai fantasmi del disastro. L’atmosfera è allucinante. Tutto è come il 26 aprile dell’86. In un asilo il segno del tempo che si è fermato: i pannelli dell’ex Unione Sovietica, i quaderni, le merendine lasciate sui banchi. Ci permettono di filmare. Entriamo in una casa, lentamente cercando di non sollevare polvere. Giriamo per le stanze di un appartamento al secondo piano, pieno di erbacce, quando sentiamo le note di un pianoforte. E’ Valerij che suona, tra le lacrime: “Questa era la mia casa. Eravamo una famiglia numerosa, allegra. Ogni tanto torno nella mia stanza a suonare ma adesso è una musica di dolore”.
Valerij è arrivato fra i primi quella notte. Alla tv di Kiev sapevano che abitava lì e gli chiesero di andare a vedere quello che sembrava un normale incidente. E’ salito sull’elicottero dei vigili del fuoco e ha girato quelle immagini ormai storiche del reattore n.4 esploso. Sono tutti morti: lui no, anche se è andato tre volte in coma. [Fino all’ultima volta in cui sono andato, dieci anni fa, era ancora vivo anche se molto debole. Adesso non so].
Andiamo avanti. Ed ecco il sarcofago di Chernobyl, una bara gigantesca. Dentro, nascosto da lastroni di piombo e cemento che sono costati la vita agli elicotteristi che li hanno gettati, c’è il reattore n.4, quello dell’apocalisse. Tecnicamente è stato spento, ma di fatto il cuore atomico è ancora attivo. Arriviamo a meno di duecento metri dall’incubo del mondo. Il contatore geiger impazzisce. Qualcuno, a suo tempo, è addirittura entrato nel sarcofago. Tecnici della stazione, per cercare il corpo del vicedirettore sparito al momento dell’esplosione. Dentro non sopravvivono neppure i batteri. Dalle immagini sul monitor si intuiscono blocchi di lava composti da uranio, plutonio, scorie di tutti i tipi, piombo, cemento che neppure un bazooka riuscirebbe a scalfire. “E’ come entrare nel corpo del diavolo e vedere il suo cuore”, ci dicono.
Il sarcofago si sta sgretolando. Colpa dell’enorme calore. Gli esperti hanno trovato numerose crepe in cui si sta infiltrando pericolosamente acqua. Si sta cercando in qualche maniera di intervenire ma c’è un altro grande rischio: che la struttura crolli sotto il proprio peso. Sarebbe necessario un ulteriore isolamento che costerebbe una cifra incredibile, quattromila miliardi di dollari. Un investimento che il governo di Kiev non può permettersi e che chiede all’Occidente.
Entriamo eccezionalmente nella centrale. Il cuore del diavolo sta in fondo: ci divide solo un tramezzo. Siamo nella grande sala delle turbine, sotto giacciono ancora mille tonnellate di uranio e plutonio. Quella notte è esplosa proprio una turbina. In fondo a un lungo corridoio, c’è la sala controllo. Sul monitor compare il reattore n. 3, l’unico insieme al numero uno che ancora funziona. Ma che è successo quella notte? La testimonianza è di Serghei Sharshun, capoturno di allora: “Nessuno si aspettava il disastro. Anche perché non doveva succedere. Ci sono stati almeno tre errori, sono arrivati ordini sbagliati. Noi superstiti non ci sentiamo fortunati. Ho sensi di colpa che nessuno potrà mai cancellare. Mio figlio sta male, mia moglie sta morendo. Non doveva succedere. Ho la nausea di questo lavoro ma starò qui fino alla fine perchè è il mio destino. Odio soltanto chi non ci ha mai avvertito dei rischi che correvamo”.
L’incidente avvenne all’una e 23 di notte. Nel corso di un test definito di sicurezza, il personale interruppe l’energia violando numerose norme, anche di buonsenso, portando a un brusco e incontrollato aumento della potenza (e quindi della temperatura) del nocciolo del reattore n. 4, di tipo RBMK-1000, a canali, usato per produrre elettricità per uso civile e plutonio per quello militare. Si determinò così la scissione dell’acqua di refrigerazione in idrogeno e ossigeno a così elevate pressioni da provocare la rottura delle tubazioni. Il contatto dell’idrogeno e della grafite incandescente delle barre di controllo con l’aria, a sua volta, innescò una fortissima esplosione, che provocò lo scoperchiamento del reattore che a sua volta innescò un vasto incendio. Una nuvola di materiale radioattivo fuoriuscì dal reattore e ricadde su vaste aree intorno alla centrale, contaminandole pesantemente. Nubi radioattive raggiunsero anche l’Europa orientale. Associazioni antinucleariste internazionali presentano una stima di sei milioni di decessi presunti su scala mondiale.
Usciamo dalla centrale, la temperatura è scesa improvvisamente a meno dieci gradi, si gela. Fra Pripyat e la stazione nucleare, accanto a una serra, c’è quello che chiamano il “poligono biologico”. E’ la zona degli esperimenti, dove sono stati piantati i semi raccolti nel bosco irrimediabilmente contaminato, morto da tempo. Le chiamano le piante mutanti. “Gli aghi di un pino normale crescono a coppie, cioè due alla volta. Qui sono tre o quattro. Altri crescono direttamente dal tronco. E il tronco, cioè il legno, qualche volta è morbidissimo altre volte è duro come quello di un faggio. Alcuni pini mutanti neppure hanno il tronco. Gli scienziati hanno accertato trentadue fattori mutanti”.
Pripyat non è deserta. Ci sono tecnici e operai che ancora lavorano alla stazione. “Mi sento un po’ debole, nient’altro. Facciamo turni di quindici giorni poi scappiamo. Lo stipendio? Beh, è il doppio rispetto alla media. Io guadagno quasi mille rubli al mese”. Mille rubli, al cambio nero, equivalgono a meno di dieci dollari. In lontananza, oltre a un cimitero di mezzi militari c’era un altro villaggio: è stato raso al suolo e seppellito, come altri dodici nella zona. Così come un intero bosco. Tutto sotto terra.
Giriamo per la campagna, arriviamo a Kupovatoe, un villaggio dove alcuni vecchi contadini hanno deciso di tornare, sfidando la morte. “Sono tornata perchè era impossibile vivere dove ci avevano sistemato. Tre o quattro famiglie per casa. E non c’era il giardino. Pensare che ci hanno messo due giorni per evacuarci. Paura? No, non ho paura. Sono vecchia ormai. Mi chiamo Olga. Sono felice perchè è la prima volta in vita mia che vedo un italiano. Nessuno mi viene a trovare, neppure i figli. Hanno paura. Ormai non mi resta che aspettare la morte, qui. Spero che arrivi presto. Se ho paura di stare qui? No, perchè la mia dose ormai l’ho presa, sarà quel che sarà. Sono dei criminali. Ci hanno fatto stare qui due giorni prima di evacuarci. E’ già un miracolo che non siamo morti subito”. Prima di andare via, mi offre i semi della sua campagna contaminata. Non ho il coraggio di rifiutarli.
Alzo lo sguardo per vedere l’ora ma scorgo in lontananza il solito pannello digitale che segna il livello di radioattività. Oggi è un po’ sceso, siamo a 84 microroentgen, l’unità di misura delle radiazioni. Che strano posto, dove l’orologio segna non il tempo, ma la vita.
Andiamo via che è buio. A Chernobyl sta per cominciare un’altra notte di paura. Perché ogni notte, da queste parti, può somigliare a quella. E se succedesse un’altra volta, lo sanno tutti, sarebbe l’ultima. Lasciamo la zona che è notte. Sarà un’impressione, ma sento il mostro che rantola. Passo il controllo, nella sala di decontaminazione. La macchina ci definisce “chisti“, puliti. Ma sarà vero?
Il secondo viaggio (1986). Torno per il decennale, più attrezzato ma la paura è la stessa. Da allora, da quella notte, ci sono stati altri due incidenti. Un corto circuito al turbogeneratore del reattore n.2. e poi una fuga dal reattore numero uno ha alzato il livello di radioattività da 57 a circa 90 microroentgen. Mi hanno spiegato che in una città come Milano il livello è assestato intorno ai 20 e mi vengono i brividi.
Ogni anno duemila bambini si ammalano ancora oggi di cancro. Sono nati molti anni dopo l’apocalisse ma il mostro li ha contagiati irrimediabilmente Li portano a Ivankiv, alla periferia di Kiev, all’ospedale pediatrico oncologico. Ci accoglie la caposala, Tatiana Michailova: “Arrivano tanti neonati, colpiti della miseria. Le ragazze fanno i figli per ricevere il sussidio dello Stato, ottomila grivna (1200 euro), poi scoprono che non è così facile e allora lasciano i figli”. Inna ha diciassette anni, la sua bimba, Daria, appena quattro mesi: “Devo lasciarla qui, sono sola. Da quando mio padre ci ha abbandonate mia madre si è messa a bere, ormai è pazza, non posso tornare da lei. Il ragazzo con cui ho fatto Daria è sparito. Adesso cerco una soluzione, ho avuto tante promesse prima delle elezioni, ma adesso non si fa più vivo nessuno”. Nell’ospedale ci sono molti altri bambini. In apparenza stanno meglio ma hanno comunque il destino segnato. “Soltanto il 12 per cento dei bambini di questa zona nasce sano” mi dice piena di angoscia Tatiana Kiliscinska, un’altra infermiera. “I più gravi sono colpiti alla tiroide – mi dice un medico, Alexander Musienko – ma quasi tutti hanno problemi agli apparati respiratori. Dovrebbero cambiare aria”. Spiega il primario di pediatria, Grigoriy Klimnuk: “Ogni giorno in media arrivano da noi due bambini, da tutta l’Ucraina. In un reparto che ne può ospitare duecento siamo arrivati ad averne anche il doppio. Tutti colpiti da tumori solidi. Purtroppo abbiamo grosse carenze economiche. Il governo copre soltanto il 30-40 per cento delle spese per la terapia d’urto, con altri finanziamenti privati arriviamo a coprire il 70 per cento ma è sempre poco. Ne riusciamo a salvare soltanto la metà”.
I bambini giocano con i colori, qualcuno addirittura riesce a sorridere. Le mamme sono nei corridoi, nelle stanze. Urlando l’allarme per la miseria che aggrava una situazione drammatica. “Come facciamo? Qui si guadagnano cento euro al mese e una cura costa diecimila euro, impossibile. Manca tutto, mancano anche le siringhe”. Per l’anniversario dell’apocalisse, c’è un concerto tutto dedicato ai bambini di Ivaniv. Ma il loro sogno è un altro. E’ il sogno di curarsi, di allontanarsi da qui. Il sogno è vivere.
Il terzo viaggio (2006). Nove milioni di persone, un’area contaminata di oltre 150 mila chilometri quadrati. Decine di migliaia di morti e chissà ancora quanti dovranno morire. Dubova è uno dei pochi villaggi ancora abitati. Ci vivono 150 persone, tutte poverissime, al limite della disperazione. Sofia è molto triste, aspetta di morire, non le rimane altro. Ha 78 anni, da trenta vive qui: “Quella notte non ci siamo accorti di nulla, dormivamo. Abbiamo capito che qualcosa di grave era successo nei giorni successivi perché c’era tanto movimento, gente che portavano via. Poi cominciò a capire tutto mio marito che lavorava in una fattoria vicino a Pripyat. Mi raccontava che facevano gli esami a tutte le bestie e poi nei mesi dopo che succedevano cose strane, mucche con due teste, maiali con una testa e due corpi. Sono venuti anche da noi a farci le visite. Ma non ci hanno portato via, segno che stavamo meglio degli altri. Però mio marito, Micha, ha cominciato a sentirsi male fin che è morto. Per tanto tempo mi hanno dato da mangiare granoturco, dicevano che serviva per guarire. Io non sono morta, sto ancora qui, ma con Micha non abbiamo fatto in tempo a fare figli e sono sola, che altro mi resta oltre che aspettare?”
Michailo ha vent’anni. Quando è successo aveva pochi mesi. E’ di poche parole, le sue giornate le passa andando in bicicletta su e giù per il villaggio: “Che devo dire? Ogni tanto qualcuno muore. Noi siamo vivi. E stiamo qui”. Victor ha trent’anni, ha due figli. Fa il muratore a Kiev, guadagna a malapena per far mangiare la famiglia: “Perché non andiamo tutti a Kiev? Perché costa troppo. Qui rischiamo, ma non c’è scelta”. Vasilj ha lavorato per quattordici anni alla centrale, adesso è in pensione: “Quello che mi porto appresso è un forte mal di testa, il mio compagno di viaggio”. Gala e Vala sono due donne energiche: “Sanno tutti che questa è una zona maledetta, che la terra è contaminata e qualsiasi cosa coltiviamo ci può uccidere. E loro che fanno? Ci danno il contributo per quelli che chiamano i prodotti alimentari puliti. Sa quanto ci danno? Un grivna al mese, basta a malapena a comprare un chilo di pane. Noi dovremmo vivere con un chilo di pane al mese. Come dire: mangiate quello che avete, altro che pulito, arrangiatevi, morite”.
Policje è il distretto a ridosso dell’apocalisse, la zona rossa numero quattro. Nykola Martynenko è il vicesindaco: “Ci sentiamo i sopravvissuti. Qui vivevano 30 mila persone, adesso siamo rimasti solo in seimila. Ma soltanto mille sono quelli in età lavorativa, gli altri o sono vecchi o sono bambini. Il futuro è ancora peggiore perché ogni quattro morti c’è soltanto una nascita. La metà dei villaggi non esiste più: erano sessanta, ne sono rimasti abitati trenta, alcuni con pochissime persone”. Davanti alla chiesa nuova ci sono le tombe più tristi. Sulle lapidi non i nomi delle persone ma dei villaggi morti. Ne visitiamo uno, fra i tanti, sommerso dagli arbusti. Questa è zona di funghi ma nessuno ci si avvicina più. L’unico luogo vivo, è un paradosso drammatico, è il cimitero dove ancora vanno i parenti a pregare.
Torniamo a Pripyat, impossibile non tornare. Vladimir Ivanovic era un tecnico della centrale, uno dei primi ad arrivare qui, già nel 1976. Quando successe la catastrofe scappò subito a casa, dalla moglie e dalla figlia Tatiana che allora aveva cinque anni. Torna spesso qui, dov’era la loro casa ma per la prima volta oggi porta tutta la famiglia. “Sapevo che era successo il finimondo. Non aspettai le autorità, non aspettai nessuno. Presi loro, le misi in auto e le portai lontano. La nostra vita non è cambiata, ringraziando Iddio, sono nate anche due gemelle qualche anno dopo. Ma tornare qui ci fa male. Una grande nostalgia. Pripyat era una bellissima città, giovane, viva. Che angoscia trovarla così, morta, sepolta dagli arbusti”.
La centrale è ufficialmente chiusa dal 2000 ma di fatto è ancora funzionante. Non produce più energia, ma non è spenta. Molti operai stanno lavorando alla disattivazione dei reattori uno e due. Un impegno difficile e soprattutto lungo. “Lavoriamo sette ore al giorno per un massimo di ventidue giorni consecutivi. Andare oltre questa soglia ci costerebbe la vita.” Nessuno lo ammette, ma ci vorrà almeno un secolo prima di scongiurare definitivamente il pericolo. Certo non si azzarda in previsioni Irina Kovlich, portavoce della centrale: “Non possiamo prevedere quanto ancora ci vorrà. L’aspetto più complicato riguarda lo smaltimento delle scorie. In sostanza, non è stato spento l’interruttore, alcuni sistemi sono ancora funzionanti. Ma non è così facile come spegnere la luce. Il mostro non ci permetterebbe altri errori”.
Vivere a Chernobyl. Tra la vita e soprattutto la morte.
Le altre Chernobyl. Il dramma vero è che le “Chernobyl” sovietiche sono molte. C’è chi dice che il disastro di Pripyat sia soltanto il settimo in ordine di gravità. Fino a qualche anno fa esistevano dieci città nucleari neppure segnate sulla carta geografica. Conosciute solo in codice, come “Tomsk 2” o “Arzamas 16”, abitate da ottocentomila fantasmi: perchè ovviamente anche loro non esistevano, in nessuna anagrafe. Situazioni di questo genere ce ne sono molte nello smisurato ex impero sovietico. Pochi sanno che nel 1961 l’equipaggio di un sommergibile nucleare si sacrificò per evitare una catastrofe sottomarina. O anche dell’esplosione, nel 1957, nell’industria Majak negli Urali che, in una delle città segrete (“Celiabinsk 65”), produceva esplosivo per le bombe atomiche. E poi l’incendio nel 1978 nella centrale atomica di Beloiarski. I quarantasei militari morti nel laboratorio di Sverdlovsk specializzato in armi batteriologiche. Il genocidio nel Kazakistan dove centinaia di migliaia di persone sono state uccise dalla radioattività del poligono di Semipalatinsk. E la morte del lago Aral, il quarto del mondo per grandezza, dove ogni anno spariscono venticinque chilometri quadrati di acqua. Pochi sanno, anche, che a Tiumei, in Siberia, ogni forma di vita è stata cancellata da una nube tossica: lo scoprì Krikaliev, l’ultimo eroe russo dello spazio, abbandonato per un anno sulla Mir. E nessuno sa cosa sta succedendo a ridosso del polo nord. Una zona maledetta, territorio di “test” nucleari, soprattutto negli anni della guerra fredda e del grande armamento. Chi paga, in maniera irreversibile, è la popolazione eschimese, vittima di continue, ininterrotte piogge radioattive. Molti di loro nascono malati di mente, sicuramente muoiono molto presto, il dramma di un popolo destinato a sparire dalla terra.
Spinti dall’Organizacja, come in Russia chiamano la mafia, tecnici ormai alla fame per vivere pare che adesso commercino plutonio, uranio e mercurio rosso. Vere e proprie bombe ambulanti in giro per il mondo. A Mosca, in pieno centro, sotto almeno tre cortili ci sono sostanze altamente nocive: arsenico, mercurio e piombo. Sono depositate da decenni dal terzo dipartimento medico del comitato centrale del Pcus, dipartimento intitolato a Lenin, che ha come compito principale la conservazione, nel mausoleo in piazza Rossa, della salma del padre del comunismo. Anche quegli additivi sono serviti insomma per costruire la grande utopia. Come dire che la gente paga due volte.




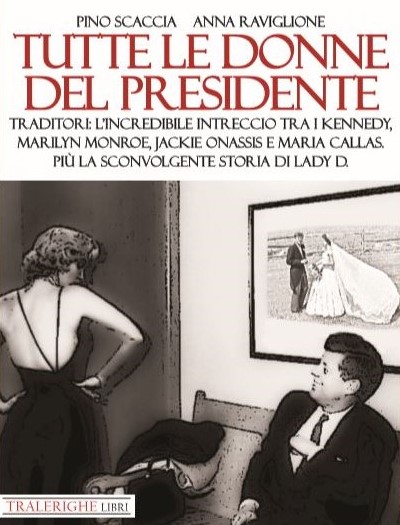

Letto. Grazie mille.
Posted by Valerio | 26 April 2016, 14:39sono molti anni e si muore ancora
Posted by ceglieterrestre | 26 April 2016, 19:47